La crisi climatica si combinerà con la crisi del capitale.
di François Chesnais*
Il punto di visto che sosterrò è che con la crisi iniziata nell’agosto 2007 si è prodotta una vera e propria rottura che pone fine a una lunga fase di espansione dell’economia mondiale. Questa rottura annuncia l’inizio di un processo di crisi le cui caratteristiche, quanto al numero dei fattori che vi si intrecciano, sono paragonabili a quelle del 1929, anche se si svolge in un contesto molto differente e se i fattori sono necessariamente differenti.
È importante in primo luogo ricordare che la crisi del 1929 si è sviluppata come un processo: un lungo processo che è iniziato nel 1929 con il crac di Wall Street, ma il cui punto culminante si è avuto in seguito, nel 1933, e che la crisi è stata seguita da una lunga fase di recessione che ha avuto per sbocco la seconda guerra mondiale. Dico questo per sottolineare che, a mio avviso, stiamo assistendo alle prime fasi, veramente le primissime, all’inizio di un processo di un’ampiezza e di una temporalità analoghe, anche se le analogie finiscono qui. Quanto sta accadendo in questi giorni sulla scena dei mercati finanziari di New York, di Londra e degli altri grandi centri borsistici è solo una delle dimensioni –e quasi certamente non la più importante– di un processo che deve essere interpretato come una cesura storica.
Siamo in presenza della forma di crisi della quale Marx diceva che segnava i limiti storici del capitalismo, dove tutte le contraddizioni si congiungono. Dire questo non significa sostenere una qualsiasi versione della teoria della «crisi finale» del capitalismo o alcunché di simile. Ciò di cui si tratta, a mio avviso, è comprendere che ci troviamo di fronte a una situazione nella quale i limiti storici della produzione capitalistica sono evidenti. Che cosa si intende con questa affermazione? Anche se non voglio passare per un predicatore marxista, vi leggerò un passo del Capitale:
«Il vero limite della produzione capitalistica, è il capitale stesso; è il fatto che il capitale e la sua autovalorizzazione appaiono come punto di partenza e punto di arrivo, come movente e come fine della produzione; il fatto che la produzione è soltanto produzione per il capitale e non, inversamente, i mezzi di produzione sono puri e semplici mezzi per una espansione sempre più diversificata e completa del processo di vita per la società dei produttori. l confini entro i quali soltanto può muoversi la conservazione e valorizzazione del valore capitale, poggiante sull’espropriazione e l’immiserimento della grande massa dei produttori, entrano perciò continuamente in conflitto con i metodi di produzione che il capitale deve utilizzare per i suoi scopi, e che tendono ad un aumento illimitato della produzione, alla produzione come fine in sé, all’incondizionato sviluppo delle forze produttive sociali – entrano in permanente conflitto con il fine angusto, della valorizzazione del capitale esistente. Se perciò il modo di produzione capitalistico è un mezzo storico per sviluppare la forza produttiva materiale e creare il mercato mondiale ad essa corrispondente, è al tempo stesso la contraddIzione permanente fra questa sua missione storica e i rapporti sociali di produzione che gli corrispondono»([1])
Due dimensioni che danno alla crisi la sua novità
Vi sono certamente alcuni termini che oggi non utilizzeremmo più, come quello di «missione storica». Viceversa, penso che la crisi che vedremo nel corso dei prossimi anni, si svilupperà precisamente sulla base di questo mercato mondiale di cui Marx aveva avuto l’intuizione e che esiste ormai in tutta la sua pienezza. È uno dei punti in cui abbiamo a che fare con una situazione mondiale diversa da quella del 1929. Paesi come la Cina e l’India, che erano allora paesi semicoloniali, oggi non hanno più tale carattere. I loro tratti specifici (espressione dello sviluppo ineguale e combinato) necessitano un’analisi attenta. Ma sono paesi che ormai partecipano a pieno titolo ad una economia mondiale unica, una economia mondiale unificata su una scala finora sconosciuta fino a questa fase della storia.
La crisi che è iniziata ha dunque per contesto un mondo che è unico in un senso diverso da quello che aveva nel 1929. È un primo punto. Ed eccone un secondo. A mio avviso, in questa nuova fase storica, la crisi si svilupperà in modo tale che la realtà brutale della crisi climatica mondiale, della quale vediamo le prime manifestazioni, si combinerà con la crisi del capitale in quanto tale. Stiamo entrando in una fase che è realmente quella della crisi dell’umanità nelle sue complesse relazioni. Queste includono le guerre. Ma anche se escludiamo lo scatenamento di una guerra di grande ampiezza, una guerra mondiale, che ai nostri giorni non potrebbe essere che una guerra nucleare, siamo di fronte a un nuovo tipo di crisi, la combinazione della crisi economica che è iniziata in una situazione in cui la natura, trattata senza riguardi e brutalizzata dall’Uomo nel quadro del capitalismo, reagisce in maniera brutale. È qualche cosa che è quasi escluso dalle nostre discussioni ma che si imporrà come un fenomeno centrale.
Ad esempio, ho appreso molto di recente dalla lettura di un libro di un sociologo francese, Franck Poupeau ([2]), che i ghiacciai andini, dai quali proviene l’acqua che rifornisce La Paz e El Alto (Bolivia), sono esauriti per più dell’80%, e che si stima che tra una quindicina d’anni La Paz e El Alto non avranno più acqua…. Si tratta di qualche cosa che noi, che ci diciamo marxisti rivoluzionari, non abbiamo mai trattato. Non discutiamo mai di fatti di tale natura e di tale ampiezza. Ora, questo fatto può far sì che la lotta di classe in Bolivia, quale noi la conosciamo, si modifichi in maniera sostanziale: ad esempio, che lo spostamento tanto controverso della capitale a Sucre, si imponga come un fenomeno «naturale», visto che La Paz mancherà di acqua. Stiamo entrando in un periodo in cui fatti dello stesso tipo interferiranno nella lotta di classe. Il problema è che negli ambienti rivoluzionari quasi nessuno ne parla; si continua a discutere di cose attualmente di infima importanza, di questioni totalmente meschine in confronto alle sfide che dobbiamo affrontare.
I tre mezzi messi in opera per superare i «limiti immanenti al capitale»
Per continuare sulla questione dei limiti del capitalismo, vorrei rimandarvi a una citazione di Marx che precede quella già fatta: «La produzione capitalista tende incessantemente a superare questi suoi limiti immanenti, ma li supera solo con mezzi che le contrappongono di nuovo, e su scala più imponente, questi stessi limiti.»([3]) C’è qui un filo conduttore che può servire nell’analisi e nella discussione. I mezzi messi in opera dalla borghesia, schierata dietro gli Stati Uniti, per superare i limiti inerenti del capitale, nel corso degli ultimi trent’anni sono stati essenzialmente tre.
Il primo è stato l’insieme del processo di liberalizzazione delle finanze, del commercio e dell’investimento, vale a dire tutto il processo di distruzione delle relazioni politiche che erano sorte sulla base della crisi del 1929 e degli anni trenta, dopo la seconda guerra mondiale, la rivoluzione cinese e le guerre di liberazione nazionale. Tutte queste relazioni, che in Europa occidentale e in America latina non toccavano l’esistenza del capitale ma rappresentavano allo stesso tempo forme di controllo parziale su di esso, sono state distrutte. Il secondo mezzo impiegato per superare i limiti immanenti del capitale è stato il ricorso, su una scala senza precedenti, alla creazione di capitale fittizio e di forme di credito che, nei paesi al centro del sistema, allargavano una domanda insufficiente. Il terzo mezzo, il più importante storicamente per il capitale, è stato il reintegro in quanto componenti di pieno diritto del sistema capitalistico mondiale, dell’Unione Sovietica e dei suoi «satelliti», così come e soprattutto della Cina, ancor più importante in quanto segnata da una modificazione controllata dei rapporti di proprietà e di produzione.
È nel quadro degli effetti contraddittori di questi tre processi che è possibile cogliere l’ampiezza e la novità della crisi che si è aperta.
Liberalizzazione, mercato mondiale concorrenza…
Vediamo dapprima gli effetti contraddittori della liberalizzazione e della deregolamentazione su scala mondiale nello spazio creato dall’integrazione al capitalismo dell’ex «campo» sovietico dopo il crollo dell’URSS, e di quella della Cina. Il processo di liberalizzazione ha comportato lo smantellamento dei pochi elementi di regolazione costruiti nel quadro internazionale all’uscita dalla seconda guerra mondiale, e ha portato a un capitalismo quasi totalmente privo di meccanismi di regolazione. Il capitalismo non solo è stato deregolamentato, ma ha creato realmente e pienamente il mercato mondiale, trasformando in realtà quella che per Marx era stata in gran parte una intuizione e un’anticipazione. È utile precisare il concetto di mercato mondiale. Il termine «mercato» designa uno spazio di valorizzazione liberato da restrizioni per le operazioni del capitale, che permette a quest’ultimo di produrre e realizzare il plusvalore prendendo questo spazio come base per meccanismi di centralizzazione e di concentrazione veramente internazionali. Questo spazio aperto, non omogeneo, ma con una riduzione draconiana degli ostacoli alla mobilità del capitale, gli permette di organizzare il ciclo di valorizzazione su scala planetaria. Si combina con una situazione che permette di mettere in concorrenza tra loro i lavoratori di tutti i paesi, vale a dire che è basato sul fatto che l’esercito industriale di riserva è veramente mondiale, e che è il capitale come un tutto che dirige, nelle forme sudiate da Marx, i flussi di integrazione dei lavoratori nel processo di accumulazione, o della loro espulsione.
Tale è dunque il quadro generale di un processo di «produzione per la produzione» nelle condizioni in cui la possibilità per l’umanità e per le masse del mondo di accedere a questa produzione è molto limitata. Per questo la conclusione positiva del ciclo di valorizzazione del capitale, per il capitale nel suo insieme e per ciascun capitale in particolare, diventa sempre più difficile da raggiungere. Ed è per questo fatto che «le cieche leggi della concorrenza» hanno una parte sempre maggiore e diventano più determinanti sul mercato mondiale. Le banche centrali e i governi possono cercare di mettersi d’accordo e di collaborare per superare la crisi, ma non penso che sia possibile introdurre la cooperazione in uno spazio mondiale diventato la scena di una concorrenza terribile tra i capitali. E attualmente la concorrenza va ben al di là dei rapporti tra i capitali delle parti più vecchie e più sviluppate del sistema mondiale. Essa include i settori meno sviluppati dal punto di vista capitalistico. Infatti, in forme particolari, comprese quelle più parassitarie, nel mercato mondiale si è prodotto un processo di centralizzazione del capitale al di fuori del quadro tradizionale dei centri imperialisti: in relazione con questi ma in condizioni che introducono anche qualche cosa di totalmente nuovo nel quadro mondiale.
Gruppi industriali capaci di integrarsi in qualità di partecipanti a pieno titolo negli oligopoli mondiali si sono sviluppati in determinati punti del sistema nel corso degli ultimi quindici anni e in particolare nel corso dell’ultima fase. In India e in Cina si sono formati veri potenti gruppi economici capitalisti. Sul piano finanziario, come espressione della rendita petrolifera e del parassitismo che le è proprio, quelli che sono chiamati Fondi sovrani sono diventati importanti punti di centralizzazione del capitale-denaro. Non sono semplici satelliti degli Stati uniti. Hanno le proprie strategie e le proprie dinamiche che modificano per molti aspetti la configurazione delle relazioni geopolitiche dei punti chiave dove si decide e si deciderà la vita del capitale.
Di conseguenza, un’altra dimensione di cui dobbiamo tener conto è che questa crisi segna la fine della fase durante la quale gli Stati Uniti potevano agire come unica potenza mondiale senza avversari. A mio avviso siamo usciti dalla fase che Meszaros aveva analizzato nel suo libro del 2001.([4]) Gli Stati Uniti saranno messi alla prova: in un tempo brevissimo le loro relazioni mondiali sono state modificate e gli Stati Uniti dovranno rinegoziarle e riorganizzarle fondandole sul fatto che devono condividere il potere. E questo è certamente un qualche cosa che non si è mai svolto in modo pacifico in tutta la storia del capitale…[sottolineatura mia. NdT]. Allora, il primo elemento è che uno dei mezzi scelti dal capitale per superare i suoi limiti è diventato una nuova fonte di tensioni, di conflitti e di contraddizioni, cosicché è una nuova fase storica che si apre attraverso questa crisi.
Creazione incontrollata di capitale fittizio
Il secondo mezzo impiegato dal capitale delle economie centrali per superare i propri limiti è stato il ricorso generalizzato alla creazione di forme totalmente artificiali di allargamento della domanda solvibile. Aggiunto ad altre forme di creazione di capitale fittizio, questo mezzo ha generato le condizioni dell’attuale crisi finanziaria. In un articolo che i compagni di Herramienta hanno avuto la gentilezza di tradurre in castigliano e di pubblicare ([5]), ho esaminato piuttosto a lungo la questione del capitale fittizio, della sua accumulazione, e dei nuovi processi che lo hanno caratterizzato. Per Marx, il capitale fittizio è l’accumulazione di titoli che sono «l’ombra» di investimenti già fatti. Sotto la forma di azioni e obbligazioni essi appaiono agli occhi dei loro detentori come un capitale. Non lo sono per il sistema nella sua totalità ma lo sono per i loro detentori e, nelle condizioni economiche «normali», al termine del processo di valorizzazione del capitale, assicurano a costoro dividendi e interessi. Ma il loro carattere fittizio si rivela in situazione di crisi. Quando si producono le crisi di sovrapproduzione, i fallimenti delle imprese, ecc., succede che questo capitale può sparire all’improvviso. Vi capita di leggere sui giornali che questa o quella quantità di capitale «è stata bruciata», in seguito a un crac di borsa? Ma queste somme non esistono in quanto capitale propriamente detto, malgrado il fatto che per i detentori di tali azioni, quei titoli rappresentavano un diritto ai dividendi e agli interessi, un diritto di ottenere una frazione del profitto.
Uno dei maggiori problemi di oggi è certamente che, in molti paesi, il sistema pensionistico è basato sul capitale fittizio, sotto forma di pretesa alla spartizione dei profitti che possono sparire nei momenti di crisi. Ciascuna fase della liberalizzazione e della mondializzazione finanziaria degli anni 1980 e 1990 ha aumentato l’accumulazione di capitale fittizio, in particolare nelle mani dei fondi di investimento, dei fondi pensione, dei fondi finanziari. E la grande novità che è apparsa all’inizio o alla metà degli anni 1990 e per tutti gli anni 2000, è che, in particolare negli Stati uniti e in Gran Bretagna, si è avuta una spinta straordinaria alla creazione di capitale fittizio sotto la forma del credito. Crediti alle imprese ma anche e soprattutto prestiti alle famiglie, crediti al consumo e ancor più crediti ipotecari. In tal modo abbiamo assistito a un salto qualitativo della massa del capitale fittizio creato, che ha provocato forme più acute di vulnerabilità e fragilità, anche in presenza di scosse minori, compreso in occasione di episodi del tutto prevedibili. Ad esempio, sulla base dell’esperienza precedente, che è stata studiata molto bene, si sapeva che il boom immobiliare sarebbe necessariamente finito per ragioni endogene ben conosciute. E se è relativamente comprensibile che sul mercato azionario esista l’illusione che non c’è limite alla crescita delle azioni, altrettanto sulla base di tutta la storia precedente, si sapeva che questo non poteva riguardare il settore immobiliare: quando si tratta di immobili e di case, è inevitabile che a un certo punto il boom finisca. Ma il grado di dipendenza dalla ricerca della crescita e del successo delle speculazioni finanziarie era talmente forte che questo avvenimento normale e prevedibile si è trasformato in elemento scatenante di una crisi enorme. Infatti bisogna aggiungere a quanto ho già detto che nel corso degli ultimi due anni del boom sono stati accordati prestiti a famiglie che non avevano la minima capacità di rimborsarli. Per di più, tutto ciò si è combinato con le nuove «tecniche» finanziarie –che ho cercato di spiegare nel modo più pedagogico possibile nell’articolo citato ripreso da Herramienta– ([6]) che hanno permesso alle banche di vendere titoli sintetici, concepiti in modo tale che nessuno poteva sapere esattamente che cosa avesse comperato. Questo spiega perché il contagio degli effetti dei «subprimes», iniziato nel 2007, ha avuto un carattere tanto devastante, e in particolare il fatto che gli «effetti tossici» abbiano avvelenato soprattutto, a un grado molto forte, le relazioni reciproche delle banche stesse.
Ora assistiamo alla «dissoluzione» [lett. Détricotage/«smagliarsi», disfarsi di un lavoro a maglia NdT] di questo processo. Bisogna cancellare un’accumulazione di «attivi» fittizi all’ennesimo grado, derivanti da tassi di indebitamento in media 30 volte l’incasso effettivo delle banche (che a sua volta comprende dei debiti, questa volta stimati «recuperabili»). Questa «dissoluzione» favorisce beninteso la concentrazione del capitale finanziario. Quando la Bank of America acquista Merrill Lynch si tratta di un classico processo di concentrazione. Il salto nella crisi a cui abbiamo assistito ieri (17 settembre) è stato provocato dalla decisione del Tesoro e della Riserva Federale di non impedire il fallimento della banca Lehman. Oggi (18 settembre) hanno già dovuto cambiare posizione e portarsi massicciamente al soccorso dell’assicuratrice AIG. Il processo di statalizzazione dei debiti implica una nuova creazione di capitale fittizio. La Riserva Federale degli Stati Uniti aumenta la massa di capitale fittizio per mantenere l’illusione del valore di centralizzazioni istituzionali di capitale fittizio (banche e fondi di investimento) sul punto di affondare, con la prospettiva di essere costretti ad un certo punto ad aumentare fortemente la pressione fiscale, cosa che in realtà il governo federale non può fare perché significa la contrazione del mercato interno e l’accelerazione della crisi. Assistiamo quindi a una fuga in avanti che non risolve nulla.
Nell’ambito di questo processo vediamo anche l’ascesa in forza dei Fondi sovrani, il cui effetto è di modificare la ripartizione intercapitalista nel campo finanziario a favore dei settori della rendita che accumulano questo tipo di fondi. Ed è un ulteriore fattore di perturbazione del processo.
Bisogna ricordare, per finire con questa seconda dimensione, che è il loro debito estero da 7 a 8 punti del Prodotto interno lordo (il PIL) che ha dato agli Stati Uniti la particolarità di essere il luogo strategico del ciclo di valorizzazione del capitale, quello che è decisivo al momento della realizzazione del plusvalore. Ciò non vale soltanto per i capitali sotto controllo statunitense, ma per il processo di valorizzazione del capitale nella sua totalità. Ora, di fronte a una recessione economica quasi inevitabile, si pone il grande interrogativo di sapere se la Cina potrà diventare quel luogo che garantirà il momento della realizzazione del plusvalore al posto degli Stati Uniti. L’ampiezza dell’intervento della Riserva Federale e del Tesoro spiega perché la contrazione dell’attività negli Stati Uniti e la caduta delle loro importazioni sono state finora piuttosto lente e limitate. L’interrogativo è di sapere quanto tempo potranno reggere con la creazione di sempre maggiore liquidità come unico strumento di politica economica. Sarebbe forse possibile che non ci sia limite alla creazione di capitale fittizio sotto forma di liquidità per mantenere il valore del capitale fittizio già esistente? Mi sembra una ipotesi molto rischiosa, e tra gli stessi economisti nordamericani molti ne dubitano.
Sovraccumulazione in Cina?
Per finire, arriviamo alla terza maniera con la quale il capitale ha cercato di superare i suoi limiti immanenti. È la più importante di tutte e quella che pone gli interrogativi più interessanti. Mi riferisco all’estensione, in particolare verso la Cina, dell’insieme del sistema di relazioni sociali di produzione del capitalismo. È un qualche cosa a cui Marx ha brevemente accennato come possibilità ma che è diventato realtà soltanto nel corso degli ultimi anni. E che si è realizzato in condizioni che moltiplicano i fattori di crisi.
L’accumulazione del capitale in Cina è stata fondata su processi interni, ma anche sulla base di qualche cosa che è perfettamente documentato ma poco commentato: il trasferimento di una parte molto importante della produzione del settore II dell’economia –il settore dei beni di consumo– dagli Stati Uniti alla Cina. Questo ha molto a che vedere con l’aumento dei deficit statunitensi (il deficit commerciale e di bilancio), che potrebbe essere ribaltato solo con un’ampia «reindustrializzazione» degli Stati Uniti.
Questo significa che si sono stabilite relazioni nuove tra gli Stati Uniti e la Cina. Non si tratta delle relazioni tra una potenza imperialista e un paese semicoloniale. Gli Stati uniti hanno creato relazioni di un tipo nuovo delle quali stentano a riconoscere e assumere le conseguenze. Basandosi sul suo eccedente commerciale, la Cina ha accumulato centinaia di milioni di dollari che ha immediatamente prestato agli Stati Uniti. Una illustrazione delle conseguenze è stata la nazionalizzazione delle due imprese denominate Fannie Mae e Freddie Mac: la Bank of China deteneva il 15% delle due imprese e ha informato il governo statunitense che non avrebbe accettato la loro svalorizzazione. Si tratta di relazioni internazionali di un tipo del tutto nuovo.
Ma che succederà se la crisi si propaga sotto forma di una riduzione importante delle esportazioni con effetti sulla produzione, di crisi della borsa di Shanghai e del sistema bancario in Cina? Nel mio articolo già menzionato ([7]) c’è una sola pagina su tale questione proprio alla fine, ma in qualche modo è la questione più decisiva per la prossima fase della crisi.
In Cina c’è stato un processo interno di concorrenza tra capitali, combinato con un processo di rivalità tra settori dell’apparato politico cinese e della concorrenza tra loro per attirare le imprese straniere. Dall’insieme, è risultato, oltre a una distruzione della natura su vastissima scala, un processo di creazione di immense capacità di produzione: in Cina è concentrata una sovraccumulazione di capitale, che a un certo punto diventerà insostenibile. Per l’Europa è notoria l’accelerazione da parte dei grandi gruppi industriali della delocalizzazione delle capacità produttive e dei posti di lavoro, per trasferirli verso questo paradiso unico del mondo capitalistico che è oggi la Cina. La mia ipotesi è che questo trasferimento dei capitali in Cina ha provocato una mutazione del movimento anteriore dell’accumulazione e provocato un nuovo aumento della composizione organica del capitale. L’accumulazione in mezzi di produzione è intensa e causa un grande spreco di materie prime, l’altra componente del capitale costante. La massiccia creazione di capacità di produzione nel settore I (mezzi di produzione) è stata il motore della crescita della Cina, ma il mercato finale che permette di smerciare tale produzione e realizzare il valore e il plusvalore è il mercato mondiale. L’aggravarsi della recessione metterà in evidenza la sovraccumulazione del capitale. Michel Aglietta, che l’ha studiata specificamente ([8]), afferma che c’è realmente una sovraccumulazione, che c’è stato un processo accelerato di creazione di capacità produttive in Cina, un processo che porrà problemi di realizzazione di tutta questa produzione nel momento in cui il mercato esterno si contrae, cosa che comincia a fare ora. La Cina ha una parte veramente decisiva, in quanto anche piccole variazioni della sua economia determinano la congiuntura di numerosi altri paesi del mondo. È bastato che la domanda cinese di beni di investimento cedesse un po’ per fare sì che la Germania perda esportazioni ed entri in recessione. Le «piccole oscillazioni» in Cina hanno ripercussioni molto forti altrove, come dovrebbe essere evidente nel caso dell’Argentina.
Per continuare a riflettere e discutere
Riprendo quanto ho detto all’inizio. Le fasi di questa crisi saranno distinte da quella del 1929, anche se sono paragonabili, dato che allora la crisi di sovrapproduzione degli Stati Uniti si è prodotta fin dai primi momenti. Dopo si è approfondita, ma era chiaro fin dall’inizio che si trattava di una crisi di sovrapproduzione. Oggi, al contrario, le politiche messe in atto dai grandi paesi capitalisti centrali ritardano questo momento, ma non possono fare molto di più di questo.
Allo stesso tempo, e come è accaduto nel caso della crisi del 1929 e degli anni 1930, anche se in condizioni e sotto forme differenti, la crisi si combinerà con la necessità per il capitalismo di una riorganizzazione totale dei suoi rapporti di forza economici su scala mondiale, il che segnerà il momento in cui gli Stati uniti vedranno che la loro supremazia militare non è che un elemento, e un elemento subordinato, per rinegoziare le loro relazioni con la Cina e le altre parti del mondo. A meno, ovviamente, che non si imbarchino in un’avventura militare dalle conseguenze imprevedibili. Per il momento le condizioni politiche interne non lo permettono in alcun modo, ma ciò non può essere escluso se la recessione conducesse a una lunga depressione e a movimenti rivoluzionari.
Per tutte queste ragioni, concludo che abbiamo a che fare con molto di più che una crisi finanziaria, anche se per ora siamo a questo stadio. Anche se questa sera mi sono dovuto concentrare sul tentativo di chiarire i grovigli del capitale fittizio e aiutare a comprendere perché è tanto difficile smontare questo capitale, siamo di fronte a una crisi infinitamente più ampia.
Tenendo conto delle domande e osservazioni che mi sono state fatte dopo il mio arrivo a Buenos Aires e anche qui questa sera, ho l’impressione che molti pensino che io traccio un quadro catastrofista del momento attuale del capitalismo. Penso in realtà che siamo di fronte a un rischio di catastrofe, non una catastrofe del capitalismo, non una «crisi finale», ma una catastrofe dell’umanità. Se prendiamo sul serio la crisi climatica, probabilmente c’è già qualche cosa di questa. Penso, come Meszaros ad esempio ([9]), ma siamo poco numerosi ad attribuirvi la stessa importanza, che su questo piano siamo già di fronte a un pericolo imminente. È tragico che per il momento sono colpite direttamente solo le popolazioni la cui esistenza non conta: quel che può accadere ad Haiti sembra non avere alcuna importanza storica, quello che accade in Bangladesh non ha peso al di fuori della regione colpita, né quello che è successo in Birmania, poiché il controllo della giunta militare impedisce che sia conosciuto. In Cina, la stessa cosa: si discute degli indici di crescita ma non delle catastrofi ecologiche, poiché l’apparato repressivo controlla le informazioni in proposito.
Il peggio è che l’opinione che «la crisi ecologica non è così grave come si dice» costantemente diffusa dai media, è interiorizzata molto profondamente, compreso da molti intellettuali di sinistra. Avevo iniziato a lavorare e a scrivere su questo argomento, ma con l’inizio della crisi finanziaria sono stato in qualche modo obbligato a tornare ad occuparmi delle finanze, anche se ciò non mi soddisfa tanto perché mi sembra che l’essenziale si gioca su una altro piano.
In conclusione: il fatto che tutto questo succeda dopo una fase tanto lunga, senza paralleli nella storia del capitalismo, di cinquant’anni di accumulazione ininterrotta (salvo una breve rottura nel 1974-1975), e anche che i circoli dirigenti capitalisti, in particolare le banche centrali, hanno imparato dalla crisi del 1929, tutto ciò fa sì che lo sviluppo della crisi è stato lento. Dopo il settembre 2007, il discorso dei circoli dirigenti ripete continuamente che «il peggio è dietro di noi» mentre quel che è certo è che «il peggio» è davanti a noi.
Per questo insisto sul rischio che c’è di minimizzare la gravità della situazione. E suggerisco che, nella nostra analisi e nel nostro modo di affrontare le cose dobbiamo integrare la possibilità, almeno la possibilità, che per inavvertenza anche noi potremmo avere interiorizzato il discorso che in fin dei conti «non succede niente».
■
Buenos Aires, 18 settembre 2008
Originale in francese da:
Inprecor n° 541/542, settembre/ottobre 2008.
* François Chesnais, economista, professore associato all’Università di Paris-Nord 13 Villetaneuse, membro del consiglio scientifico di ATTAC, anima il collettivo Carré Rouge (http://www.carre-rouge.org). Ha pubblicato, tra l’altro, La Mondialisation du capital (Syros, 1994 e 1997 – edizione accresciuta), Mondialisation et impérialisme (con Odile Castel, Gérard Dumesnil et al., Èd. Syllepse, Paris, 2003) e La finance mondiale – racines sociales et politiques, configuration, conséquesnces (sotto la sua direzione, La Découverte, Paris, 2004). È qui riprodotta la sua relazione presentata alla riunione della rivista argentina Herramienta, il 18 settembre 2008 a Buenos Aires, pubblicata in Herramienta n° 39 di ottobre 2008. (Traduzione dallo spagnolo rivista dall’autore).
[1]. Karl Marx, Il Capitale, Libro III, UTET, Torino, 1987 pag. 320
[2] . Franck Poupeau, Carnets boliviens 1999-2007, Un goût de poussière, Èditions Aux lieux d’être, Paris 2008
[3]. Karl Marx , ibidem.
[4] . Istvan Mészaros, Socialism or Barbarism: From the “American Century” to the Crossroads, Monthly Review Press, 2001.
[5] . «El fin de un ciclo. Alcance y rumbo de la crisis financiera », Herramienta n° 37, marzo 2008. Questo articolo è apparso prima in francese , cfr François Chesnais, «Fin d’un cycle, sur la portée et le chéminement de la crise financière », Carré rouge –La Brèche n° 1 décembre 2007-janvier 2008
[6]. Ibid.
[7]. Ibid.
[8]. Cfr. Michel Aglietta et Yves Landry, La Chine vers la superpuissance, Economica, Paris 2007.
[9]. Istvan Meszaros, The sole viable economy, Monthly Review Press, 2007, pubblicato anche in spagnolo in Herramienta n° 37 di marzo e n° 38 di giugno 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)





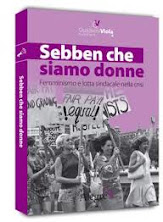







Nessun commento:
Posta un commento