di Daniel Tanuro*.
Il 26 novembre 2012 si è aperto a Doha (Qatar) il vertice annuale dell’ONU sui cambiamenti climatici. Dal punto di vista formale, il vertice comprende due incontri distinti: la 18° seduta della Conferenza delle parti che hanno sottoscritto la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (CCNUCC) conclusasi a Rio nel 1992, da un lato e l’8a seduta delle parti aderenti al Protocollo di Kyoto, dall’altro lato. I principali scopi dell’incontro sono: 1) l’assunzione da parte dei paesi sviluppati di una seconda fase di impegno ai sensi del Protocollo di Kyoto (la prima fase si chiude alla fine di quest’anno); 2)il negoziato di un accordo globale che impegni tutti gli Stati nella lotta contro il surriscaldamento, a partire dal 2020.
I due risvolti sono intimamente connessi in quanto i cosiddetti paesi “in via di sviluppo” esigono da quelli cosiddetti “sviluppati” che diano l’esempio – essendo loro i principali responsabili storici dei mutamenti climatici, mentre i secondi esigono dai principali paesi emergenti che si assumano le proprie responsabilità – in quanto oggi figurano tra i principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra.
Da Bali a Doha
Il vertice di Doha rientra nel solco delle precedenti riunioni, in particolare quelle di Bali, Copenhagen, Cancún e Durban. Per capire le poste in gioco, occorre dunque risalire un po’ indietro.
• Il vertice di Bali (2008) ha adottato una “road map” che stipula: “sono indispensabili tagli a fondo nelle emissioni globali” per stabilizzare il clima, sottolineando inoltre “l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico come indicato nel IV Rapporto di valutazione del GIEC [Gruppo di Esperti Intergovernativi sull’Evoluzione del Clima]”. Al termine di accanite discussioni contro i rappresentanti dell’amministrazione USA, è stata aggiunta una nota a pie’ di pagina al Rapporto 2007 del GIEC, che rimanda alla pagina 776 del contributo del III Gruppo di lavoro, come anche alle pagine 39 e 90 della Sintesi tecnica del suddetto contributo.
Si tratta di un dettaglio importante, poiché questi documenti forniscono diversi scenari di stabilizzazione climatica, tenendo conto delle “responsabilità comuni ma differenti” dei paesi ricchi e di quelli poveri. Secondo questi scenari, per non superare di 2°C l’aumento della temperatura rispetto al XVIII secolo: 1) la emissioni dei paesi sviluppati devono diminuire del 25-40% di qui al 2020, e dell’80-95% di qui al 2050, rispetto al livello del 1990; 2) le emissioni mondiali devono diminuire del 50-85% di qui al 2050; 3) la riduzione deve cominciare al più tardi nel 2015; 4) i paesi in via di sviluppo possono continuare ad aumentare le proprie emissioni nette per un certo periodo, ma quelle relative devono scendere del 15-30% rispetto alle proiezioni.
• A Copenhagen (2009) la road map di Bali sarebbe dovuta approdare a un’intesa globale, che fissasse per i paesi ricchi obblighi di riduzione assoluta delle loro emissioni e per gli altri paesi obblighi di riduzione relativa, in funzione dell’obiettivo di una limitazione del riscaldamento, e attraverso il trasferimento di tecnologie pulite dal Nord verso il Sud (per garantire il diritto allo sviluppo di quest’ultimo). Ma nel frattempo era intervenuta la crisi dei subprimes. Nel contesto di recessione e di esacerbata concorrenza capitalistica, i grandi inquinatori, Stati Uniti in testa, non volevano assolutamente saperne di un accordo che avrebbe minacciato la competitività delle loro imprese. Per questo, Barak Obama organizzò una trattativa ufficiosa con Cina, India, Brasile, Sud Africa e Unione Europea, che partorì un accordo che invitava ogni Stato a elaborare a suo modo il proprio piano climatico e a comunicarlo alla Segreteria della CCNUCC.
In questo modo, paesi sviluppati e grandi Stati “emergenti” sfuggirono alla minaccia di un trattato multilaterale con obbligo di rispettare obiettivi di riduzione drastica, stabiliti in base alla perizia scientifica del GIEC. La Conferenza “prese nota” di questo accordo in un clima burrascoso, contrassegnato dall’opposizione coraggiosa di alcuni Stati del Sud (Bolivia, Venezuela, Cuba, in particolare), che denunciarono il diktat delle grandi potenze. Il rappresentante di Tuvalu, da parte sua, attaccò gli Stati “in via di sviluppo” che accettavano i “denari di Giuda” come prezzo della loro sottomissione.
• Il vertice di Cancún, l’anno successivo, fu dominato dal tema dell’adattamento al riscaldamento. Anziché prendere energiche misure per ridurre le emissioni, i paesi ricchi promisero di mettere a disposizione 30 miliardi di dollari per i paesi poveri nel 2010-2012, per aiutarli ad adeguarsi al riscaldamento, e che la busta avrebbe raggiunto i 100 miliardi annui a partire dal 2020. Si decise di affidare la gestione di queste somme a un Fondo verde per il clima, in cui svolge un ruolo preminente la Banca Mondiale. La Conferenza ha affermato peraltro la necessità di limitare l’aumento di temperatura a 2°C in media, di tenere regolarmente sotto esame questo obiettivo ed anche di pensare a un consolidamento a 1,5°C come massimo, in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche sull’impatto del riscaldamento. Fin là, la sola Europa si era pronunciata per l’obiettivo dell’aumento massimo di 2°C.
Secondo logica, la decisione al vertice avrebbe dovuto portare i congressisti di Cancún a riprendere la road map di Bali e la sua famosa nota a pie’ di pagina, per adottare in fretta un piano d’urgenza che includesse le riduzioni di emissioni giudicate indispensabili dagli specialisti. Essi invece, si accontentarono di “prender nota” degli obiettivi di riduzione delle emissioni che 80 paesi avevano spontaneamente comunicato alla Segreteria della CCNUCC, secondo il modo di procedere di Copenhagen. I climatologi fecero notare che, in base a quei piani climatici nazionali, la temperatura di superficie della Terra aumenterebbe probabilmente del 3-5°c di qui a fine secolo – pressappoco due volte di più, ma non si fece nulla. Il 2°C massimo era passato in cavalleria.
• A Durban, l’anno scorso, si strapparono faticosamente due accordi, relativi rispettivamente ai paesi ricchi e a quelli poveri. Il primo stipula che vi sarà, certo, una seconda fase di impegno nel quadro del Protocollo di Kyoto (ricordiamo che la prima – 2008-2012 – ingiungeva ai paesi ricchi di ridurre le proprie emissioni del 5,2% in media, rispetto al 1990). Il secondo riconosce la necessità di elaborare “un protocollo, un altro strumento giuridico, o una conclusione concordata avente forza di legge a titolo della Convenzione (CCNUCC) applicabile a tutte le parti”. È stato avviato un processo di contrattazione di questo accordo climatico globale. Dovrebbe completarsi nel 2015, con un testo da sottoporre poi ai parlamenti nazionali di tutti gli Stati. Sempre che veda la luce, l’accordo entrerebbe in vigore come minimo nel 2020.
Slittamenti progressivi
Nel corso di questi incontri (intervallati da altre riunioni annuali, soprattutto a Bonn), si registrano vari scivolamenti.
1) Il principio delle “responsabilità comuni ma differenti” dei paesi del Nord e del Sud è stato sottoposto a pressione costante; con il pretesto che i principali paesi emergenti emettono attualmente una quota assai rilevante di gas a effetto serra immessi nell’atmosfera, si è sistematicamente relativizzata, se non cancellata, la responsabilità storica fondamentale dei paesi imperialisti (responsabili per oltre il 70% del riscaldamento).
La risposta dei governi e delle istituzioni internazionali ha assunto sempre più un taglio neoliberista, al punto di basarsi ormai quasi esclusivamente su meccanismi di mercato (incentivi alle energie rinnovabili, mercato dei diritti di emissione e acquisti di crediti d’emissione). È vero che questi meccanismi erano previsti dal Protocollo di Kyoto ma, nonostante la sua notoria insufficienza questo comunque manteneva un carattere ibrido, poiché assegnava agli Stati quote obbligatorie di riduzione delle emissioni (con sanzioni in caso di mancato rispetto). Da un lato, oggi non resta più granché di questo approccio “regolatore” – i principali inquinatori (paesi imperialisti e “sub imperialismi” emergenti, in particolare Cina e Brasile) lo hanno espunto a Copenhagen; dall’altro lato, si è considerevolmente allargata la gamma delle possibilità di sostituire le riduzioni delle emissioni con misure compensative. È così che non solo la piantagione di alberi ma anche la protezione dei boschi esistenti, la valorizzazione energetica del metano delle carbonaie, o la distruzione di alcuni gas industriali ad elevato effetto serra si considerano ormai come equivalenti a riduzioni nette di emissioni. In realtà, l’equivalenza non esiste se non nella testa di chi l’ha immaginata e la cui principale preoccupazione è quella di consentire all’industria di sostituire misure costose per ridurre le emissioni con l’acquisto di crediti di carbonio al prezzo più basso possibile, cosa che in realtà ha come effetto quello di ritardare l’indispensabile transizione energetica. [I crediti di carbonio o riduzioni certificate delle emissioni (RCE) sono attestati rilasciati a un agente, che abbia ridotto le sue emissioni di gas serra. Per convenzione, una tonnellata di anidride carbonica (CO2) corrisponde ad un credito di carbonio NdR].
Gli sceicchi del petrolio in testa alla manovra
Va da sé che la conferenza di Doha non comporterà alcun cambiamento di rotta a questa politica disastrosa. Il luogo stesso dove si svolge è emblematico. Insediato su riserve di idrocarburi e petrodollari, il Qatar ha il triste privilegio di essere il paese del mondo che emette più gas a effetto serra per abitante. Il regime è uno dei più retrogradi dell’area: alle ultime elezioni municipali, nel 2011, una sola donna è riuscita a conquistare un seggio nel consiglio comunale. Vi si calpestano i diritti umani e il paese, pur avendo abolito la schiavitù nel 1952, applica una legge scellerata, cosiddetta di “padrinato”, secondo cui i lavoratori stranieri posso entrare, soggiornare e lavorare nell’emirato, ma non possono andarsene senza l’autorizzazione del loro “padrino”.
Considerato come il cinquantunesimo Stato degli USA, il Qatar sostiene tutte le dittature della regione: è per suo tramite che Washington e Tel Aviv cercano di sabotare le rivoluzioni arabe; sostiene incondizionatamente i nuovi regimi oscurantisti islamisti (ha appena consegnato importante materiale per la repressione al ministero dell’Interno tunisino) ed è sospettato di aver trafficato nel finanziamento di progetti di colonizzazione israeliana a Gerusalemme Est. Aggiungiamo che gli emiri non sono più rispettosi della natura di quel che non lo siano con gli esseri umani: bracconieri senza scrupoli e di padre in figlio, si recano regolarmente in Nord Africa per cacciare l’otarda e la gazzella di Thomson, due specie protette che massacrano impunemente, malgrado le grida indignate delle associazioni tunisine e algerine di difesa dell’ambiente.
Ecco i personaggi che presiedono i dibattiti della XVIII Conferenza dell’ONU sul clima… Credere che questa possa tracciare il cammino che consenta all’umanità di evitare la catastrofe è più che mai un’illusione.
La catastrofe è in marcia
Vent’anni dopo l’adozione della CCNUCC, l’incuria capitalistica snocciola gli effetti sotto i nostri occhi: il riscaldamento del pianeta continua ad accelerarsi, al punto che si rischia davvero di raggiungere il punto di non ritorno. Dall’inizio del XXI secolo, le emissioni di gas a effetto serra aumentano del 3-4% l’anno, contro circa il 2% negli anni Novanta. L’aumento si spiega soprattutto con l’esplosione dei trasporti e l’accresciuta utilizzazione del carbone nell’officina cinese del mondo, ma anche in India, negli Stati Uniti e in Australia. È dunque direttamente legato alla mondializzazione neoliberista.
Di colpo, i fenomeni metereologici estremi (piogge violente, siccità anomale, canicole o gravi ondate di freddo, tempeste, cicloni…) si moltiplicano e guadagnano intensità. Lo scioglimento estivo dei ghiacci dell’Artico ha raggiunto un record assoluto nel 2012, al punto che la banchisa polare potrebbe sparire completamente in un futuro ravvicinato. Soprattutto, si osserva la preoccupante accelerazione della dislocazione della calotta glaciale della Groenlandia e dell’Antartico occidentale – fenomeno che fa correre all’umanità il rischio di fondo di un innalzamento del livello dei mari di due metri o più di qui a fine secolo.
Queste terribili minacce, di cui i poveri saranno le vittime principali, sono state ricordate di recente in un rapporto della Banca Mondiale. Intitolato “Abbassiamo il calore: occorre infatti evitare assolutamente l’innalzamento di 4°C della temperatura del pianeta” e redatto insieme da Climate Analytic e dal Potsdam Institute for Climate Impact Research, questo documento non dice niente di fondamentalmente nuovo sugli impatti dei cambiamenti climatici. Di fatto, la sua vistosa diffusione subito prima della Conferenza di Doha sembra avere soprattutto lo scopo di preparare gli animi al superamento dei 2° C. Potrebbe anche servire a legittimare, in nome dell’urgenza, le sedicenti “soluzioni” fornite dalla Banca nel quadro della sua offensiva per una “economia verde”: gli agrocarburanti, il nucleare, il carbone “pulito” e la massiccia appropriazione delle risorse naturali, soprattutto i boschi e le terre arabili.
Secondo Oxfam, gli investitori internazionali acquistano ogni sei giorni nei paesi del Sud una superficie di terra delle dimensioni di Londra. Negli ultimi dieci anni, le terre acquistate cosi costituiscono otto volte la superficie della Gran Bretagna. In Cambogia, si stima che più del 60% dei terreni coltivabili sono stati acquistati da multinazionali. Quest’ondata di appropriazioni è largamente dovuta al fatto che la finanza internazionale specula sui prezzi delle materie prime agricole e sulla produzione di agrocarburanti.. a detrimento del diritto dei popoli all’alimentazione. Ecco un esempio della barbarie di cui sono portatrici le “soluzioni” della Banca.
Ogni volta che si apre una conferenza dell’ONU sul clima, i mezzi di comunicazione di massa ci ripetono il solito ritornello: i governi ricercano un’intesa perché l’aumento della temperatura non superi i 2°C rispetto al periodo preindustriale. In realtà è più che probabile che questo obiettivo sia ormai fuori portata. Se l’Unione Europea è andata meglio rispetto all’obiettivo assegnato da Kyoto, è in gran parte grazie alla recessione economica, al’importazione di agrocarburanti, al massiccio acquisto di crediti di carbonio (spesso crediti bidone), e alla delocalizzazione della produzione in Cina. Gli Stati Uniti, com’è noto, non hanno mai ratificato gli accordi di Kyoto e le loro attuali emissioni superano di oltre il 30% quelle del 1990. Il Canada si è ritirato dal protocollo e il Giappone, come la Russia, non ne vogliono più sapere.
Eppure, il testo adottato nell’ex capitale imperiale imponeva soltanto obiettivi irrisori, insignificanti rispetto a quel che è indispensabile per salvare il clima. È quindi semplicemente impensabile che l’economia capitalistica mondiale, basata sulla crescita, la concorrenza e il profitto, riesca a mettere in atto le riduzioni drastiche evocate dalla nostra nota a pie’ di pagina della road map di Bali. Basta dare un’occhiata alle tendenze della politica capitalistica per convincersene: le fonti rinnovabili restano globalmente marginali, il loro sviluppo copre solo una parte dell’aumento della domanda; il grosso dei bisogni resta garantito dalle energie fossili, con un crescente ricorso al carbone, la febbre delle risorse petrolifere dell’Artico, il delirante sfruttamento delle sabbie bituminose dell’Alberta, senza contare quello dei gas da scisti, nuovo joker delle multinazionali dell’energia.
Il vicolo cieco capitalistico è totale
L’impossibilità di raccogliere la sfida climatico/energetica nel quadro produttivistico del capitalismo è così evidente che emerge dalle righe stesse di alcuni Rapporti di istituzioni internazionali al di sopra di ogni sospetto di sovversione comunista. A questo proposito, il World Economic and Social Survey 2011 dell’ONU costituisce una lettura edificante. Secondo questo documento, l’incidenza delle moderne rinnovabili sulla produzione primaria di energia è passata dello 0,45% nel 1990 allo 0,75% nel 2008, pari a una crescita media annua del 2,9%. Nel frattempo, l’impiego del carbone, del petrolio e del gas naturale è aumentato dell’1,6%, 1,5% e 1,2%, rispettivamente. I governi sono intervenuti massicciamente per promuovere le rinnovabili, e il settore privato ha cominciato a partire, “ma il cambio di tecnologia energetica è rallentato considerevolmente al livello del mix energetico complessivo a partire dagli anni Settanta e non si hanno prove a sostegno della convinzione popolare che questo cambiamento di tecnologia energetica conosca un’accelerazione (…) A dispetto degli impressionanti saggi di crescita della diffusione di tecnologie energetiche rinnovabili dal 2000, è evidente che l’attuale traiettoria non si avvicina da nessuna parte al percorso realistico verso la totale de-carbonizzazione del settore energetico globale nel 2050”, sostiene il Rapporto (pp. 49-50).
Una delle ragioni del paradosso è che l’utilizzazione pienamente razionale e economica delle rinnovabili richiederebbe di costruire in dieci anni un sistema energetico completamente nuovo. Spiegazione nel caso della produzione elettrica: nel quadro attuale, 1 GW di capacità eolica intermittente richiede il backup di 0,9 GW fossile. Per evitarlo, c’è bisogno di una rete “intelligente”. Ma, costruire una simile rete costituisce un’impresa “gigantesca, che richiede progresso tecnologico, collaborazione internazionale e trasferimenti senza precedenti” (p. 52). In linea generale, osserva il Rapporto, “la magnitudine fisica dell’attuale sistema energetico basato sui combustibili fossili è veramente enorme. Esistono migliaia di grandi miniere di carbone e di grandi centrali elettriche a carbone, circa 50.000 campi petroliferi, una rete mondiale di almeno 300.000 chilometri di oleodotti e di 500.000 gasdotti, e 300.000 chilometri di linee elettriche. Globalmente, il costo della sostituzione dell’infrastruttura fossile e nucleare esistente è perlomeno di 15-20.000 miliardi di dollari [da un quarto a un terzo del PIL mondiale – D.T.]. La Cina da sola ha aumentato la propria capacità elettrica a carbone di oltre 300 GW tra il 2000 e il 2008, un investimento di più di 300 miliardi di dollari, che comincerà ad ammortizzarsi a partire dal 2030-2040 e funzionerà probabilmente fino al 2050-2060. In effetti, la maggior parte delle infrastrutture energetiche sono state dispiegate di recente nelle economie emergenti e sono completamente nuove, con durate di vita di 40-60 anni almeno. Chiaramente, è improbabile che il mondo (sic) decida dall’oggi al domani di cancellare 15-20.000 miliardi di dollari di infrastrutture e di sostituirle con un sistema energetico rinnovabile il cui prezzo è più elevato” (p. 53).
Evidentemente non è il “mondo” che decide – lui non ha voce in capitolo. Sono i governi, sotto la tutela dei grandi gruppi energetici… e del capitale finanziario che eroga i crediti per gli investimenti. Le riserve comprovate di combustibili fossili – che rientrano negli attivi delle lobbies del carbone, del gas, del petrolio, ed anche dei fondi pensione – sono superiori di cinque volte al quantitativo di carbone che l’umanità può ancora permettersi di bruciare. Secondo i calcoli del Potsdam Institute e dell’ONG Carbon Tracker, per salvare il clima occorrerebbe che l’80% di quelle riserve restassero per sempre nelle profondità geologiche del globo. Per il “mondo” andrebbe meglio, ma non per i proprietari dei giacimenti, va da sé.
A parte questo piccolo “dettaglio”, il World Economic and Social Survey 2011 inquadra bene il problema. Oltre il 50% delle emissioni mondiali riguardano appena il 7% della popolazione, i 3,1 miliardi di poveri sono “responsabili” solo per il 5-10% dei gas a effetto serra (p. 29). Di conseguenza, il successo della transizione è possibile solo se “l’Europeo medio riduce il proprio consumo di energia di circa la metà e i residenti negli Stati Uniti dei tre quarti circa” (p. XIV). Il Rapporto ha l’onestà di riconoscere che obiettivi del genere non si possono raggiungere con “soluzioni semplicistiche” quali “l’internazionalizzazione delle esternalità ambientali” o le politiche spontaneistiche di “big push [sforzo molto elevato]” tecnologico. “nessuno di questi approcci ha la potenzialità di accelerare sufficientemente il cambiamento tecnologico alle scale globali richieste” (p. 29).
Per un piano d’urgenza ecologico e sociale
Gli autori del World Economic and Social Survey 2011 non traggono naturalmente la conclusione che si impone a partire dalla loro analisi. Al contrario, si ispirano allo scenario Blue map dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE). Ora, a parte il fatto che ritiene ragionevole protrarre lo sviluppo degli agrocarburanti e costruire una centrale nucleare di 1GW a settimana per quattro anni, lo scenario dell’AIE, soprattutto, permetterebbe tutt’al più di limitare la concentrazione di CO2eq a 550ppm, che corrisponde a un aumento di temperatura compreso tra 2,8° e 3,2°C…Mettere in opera la Blue map: ecco sicuramente quel che ha in testa la Banca Mondiale quando afferma che bisogna “assolutamente evitare un innalzamento di 4°C della temperatura del pianeta”…
La conclusione inevitabile ma tabù è la seguente: il salvataggio del sistema climatico è possibile solo attraverso una pianificazione democratica su scala mondiale, la soppressione di produzioni inutili o dannose, un’ampia rilocalizzazione della produzione (soprattutto agricola) e la radicale redistribuzione delle ricchezze. Essa dovrebbe comprendere in particolare: la nazionalizzazione senza indennizzo dei gruppi energetici e del credito, la drastica riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, l’abolizione dei debiti pubblici, la soppressione dei diritti di proprietà intellettuale sulle tecnologie pulite e un notevole ampliamento del settore pubblico sotto controllo delle popolazioni. Solo un orientamento anticapitalistico verso una società che produca per il soddisfacimento dei reali bisogni umani, democraticamente scelti, può consentire di ridurre drasticamente il consumo energetico e la produzione materiale può permettere di ridurre radicalmente il consumo energetico e la produzione materiale, pur consentendo di soddisfare i bisogni sociali dei più.
Il salvataggio del clima – che determina le nostre condizioni di esistenza sulla Terra – ha questo prezzo. Ciò significa che la lotta deve imperativamente essere assunta dai movimenti sociali, soprattutto dal movimento sindacale. Anziché farsi mettere alle corde mediando la “ripresa” del capitalismo, come stanno facendo, le organizzazioni dei lavoratori e delle lavoratrici dovrebbero avere il coraggio di elaborare un vasto piano pubblico di urgenza sociale ed ecologica. Un piano che puntasse, al tempo stesso, a fornire occupazione a tutti e tutte e a cancellare il mortale ingranaggio della crescita capitalistica otterrebbe un’enorme legittimazione sociale, di fronte a questo sistema che, come diceva Marx, “distrugge le due uniche fonti di qualsiasi ricchezza: la terra e il lavoro”.
[Questo testo aggiornatissimo è stato scritto da Daniel Tanuro, autore del libro L’impossibile capitalismo verde pubblicato da Alegre, il 27 novembre 2012, ossia subito dopo l’inizio della conferenza, ma aveva colto esattamente cosa sarebbe avvenuto a Doha - Dal sito di: Europe Solidale Sans Frontières. La traduzione è di Titti Pierini]
lunedì 17 dicembre 2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)






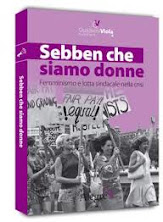







Nessun commento:
Posta un commento